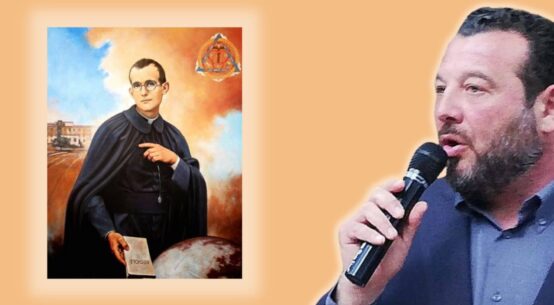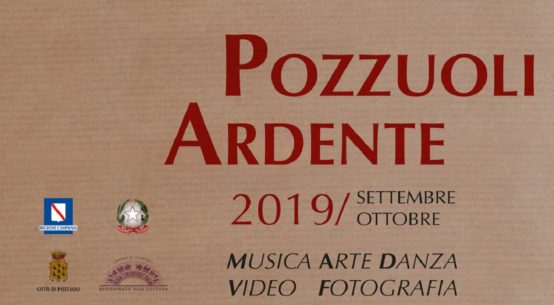Anni fa, mentre correvamo sul lungomare di Pozzuoli, con un amico runner intavolammo una conversazione sui libri che stavamo leggendo. Io da poco avevo terminato un testo sullo sciamanesimo in cui si evidenziava come nelle civiltà preistoriche e in diverse tribù moderne l’assunzione di sostanze psichedeliche da parte degli sciamani fosse l’elemento chiave per venire a contatto con il mondo degli spiriti.
Nel testo, inoltre, si diceva che di queste sostanze molti artisti ne hanno fatto uso in passato e altri ne farebbero tuttora uso per trovare l’ispirazione.
A quel punto il mio amico mi raccontò che da ragazzo un suo conoscente che amava fumare marijuana ironicamente suppose che Dante Alighieri, prima di scrivere la Divina Commedia, “si fosse fumato chissà che…”
Ne LA CHIAVE DELL’IMMORTALITÁ di Brian C. Muraresku, un testo che trae spunto da LA STRADA PER ELEUSI di Wasson-Hofman-Ruck, si avanza l’ipotesi che nei misteri eleusini si facesse uso di una bevanda psichedelica per consentire agli iniziati ai misteri di venire in contatto con il mondo divino.
L’ipotesi eretica proposta nel libro sostiene che dai misteri eleusini deriverebbe l’eucarestia cristiana per cui la stessa bevanda psicotropa o qualcosa di simile si usava agli albori del cristianesimo al posto dell’ostia e del vino usati comunemente al giorno d’oggi. A preparare la mistura psichedelica, così come avveniva nei misteri eleusini, erano le donne, ovvero le sacerdotesse.
In questo caso anche nel cristianesimo la figura femminile assumerebbe un valore prioritario in ambito cerimoniale, cosa che finora la Chiesa le ha negato impedendole di celebrare la messa.
Ne LA CHIAVE DELL’IMMORTALITÁ l’autore, a un certo punto, parlando di William Shakespeare e del suo probabile uso di sostanze psichedeliche, scrive: Nel 2015, quando è stata rilevata la firma chimica della cannabis sui frammenti di pipa ritrovati nel giardino del più celebre scrittore di lingua inglese, i giornali hanno intitolato a tutta pagina: William Shakespeare era fatto quando scrisse le sue opere? La maggior parte dei media ha ignorato che il fatto che la prima identificazione dei cannabinoidi mediante gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) risaliva al 2001 e aveva semplicemente <<suggerito>> la possibile presenza di cannabis. I risultati più definitivi, passati in gran parte inosservati, indicavano piuttosto la presenza di nicotina, cocaina e acido miristico (probabilmente derivato dalla noce moscata, che ad alte dosi è psichedelica), sostengono dell’idea che <<almeno un allucinogeno era accessibile>> a Shakespeare nel XVII secolo. (LA CHIAVE DELL’IMMORTALITÁ –MONDADORI/OSCAR BESTSELLERS MISTERI- PAG.198)
Riallacciandoci alla probabilità che il bardo inglese, così come molti altri artisti, facesse uso di sostanze stupefacenti per trarre spunto per le sue opere immortali, a ipotizzare che anche Dante possa aver scritto la Divina Commedia, e prima ancora La Vita Nova, sotto l’effetto di sostanze psicotrope fu la studiosa inglese Barbara Reynolds nel suo saggio DANTE LA VITA E L’OPERA edito da Longanesi nel 2007.
L’ipotesi della studiosa si fonderebbe sul particolare non trascurabile che Dante apparteneva alla corporazione dei medici e degli speziali, pertanto doveva conoscere bene l’uso delle erbe, i loro effetti allucinogeni e il dosaggio perché la loro assunzione non si rivelasse letale. Altro elemento a supporto di questa teoria è che i poeti già all’epoca di Danete facevano uso di sostanze psichedeliche per compiere viaggi nell’aldilà per trarre spunto per le loro opere.
Certamente questa tesi farà storcere il naso a molti. Ma non sarebbe del tutto campata in aria tenuto conto che anche D’Annunzio faceva uso di stupefacenti, in particolare di cocaina.
Nel suo testo IL LINGUAGGIO SEGRETO DI DANTE E DEI FEDELI DI AMORE Luigi Valli sostiene che Dante apparteneva ai Fedeli D’Amore, una confraternita in controtendenza con le dottrine della Chiesa. I suoi membri comunicavano tra di loro in versi scrivendo poesie dove l’esaltazione dell’amore e della figura femminile erano una metafora per nascondere ai nemici i messaggi che si scambiavano tra di loro.
A sostenere che Dante appartenesse ai Fedeli D’Amore furono, tra gli altri, Giovanni Pascoli e il poeta risorgimentale Gabriele Rossetti
Per i Fedeli d’Amore la figura femminile simboleggiava la Conoscenza Sacra professata da Cristo nei suoi insegnamenti originali. Quella conoscenza che la Chiesa degli albori, maschilista e misogina, soffocò in ogni modo combattendo e condannando quanti la professavano e praticavano, giungendo ad accusare di stregoneria le sue adepte.
Vista la venerazione che i Fedeli d’Amore nutrivano verso la figura femminile non si può escludere che tale devozione dipendesse dal fatto che fosse proprio la donna, durante le cerimonie sacre riconducibili ai riti eleusini, a preparare la bevanda da offrire durante i riti agli astanti affinché venissero in contatto con Dio.
In questa chiave di lettura davvero la donna appare come colei in grado di spalancare all’uomo le porte del Paradiso!
Se davvero fosse così, sarebbe altrettanto plausibile che l’istituzione dell’eucarestia da parte di Gesù durante l’ultima cena altro non fosse che la riproposizione edulcorata di quanto accadeva durante i misteri eleusini.
Si è sempre discusso del valore che Gesù attribuiva alle figure femminili, in particolare a Maria di Magdala.
Nel suo saggio MARIA DI MAGDALA E LE MOLTE ALTRE. DONNE SUL CAMMINO DI GESÙ la studiosa Carla Ricci evidenzia che tra i discepoli di Gesù vi era un nutrito gruppo di donne.

Possibile mai che queste donne svolgessero una funzione meramente secondaria rispetto ai maschi? Non sarebbe ipotizzabile, invece, che il loro ruolo contemplasse proprio la preparazione della bevanda sacra per le cerimonie celebrate da Gesù e dalla Maddalena?
Se i Fedeli d’Amore professavano una dottrina contrapposta a quella della Chiesa, non si può escludere che a loro volta praticassero questi antichi riti dove si faceva uso di sostanze psichedeliche per accedere al mondo divino. Pertanto non è escluso che anche Dante ne facesse uso e le sue opere sarebbero frutto delle visioni che egli avrebbe avuto durante gli stati di coscienza alterata.
E’ importante speicifcare che i Fedeli D’Amore si rifacevano alla tradizione trobadorica sorta nel XI secolo sulle coste della Francia meridionale. Per i trobadori la figura della donna e l’amore trascendevano l’aspetto materiale; erano elementi cardini per lo sviluppo interiore dell’essere. Si tenga presente che secondo la leggenda, dopo la morte di Gesù, Maria di Magdala, insieme a un gruppo di discepoli del Maestro, si imbarcò per approdare proprio sulle coste della Francia meridionale.
Nel suo libro la Ricci fa precedere il capitolo I° dalla foto di un bassorilievo presente nella cattedrale di Vieille Major, a Marsiglia, in cui la Maddalena annucia il Vangelo ai principi di Marsiglia.
Se Dante davvero apparteneva ai Fedeli D’Amore era senz’altro a conoscenza delle credenze trobadoriche e della funzione prioritaria che la figura femminile assumeva nella loro cultura. Cultura che derivava le proprie radici presumibilmente dai misteri eleusini di cui imitava non solo il credo ma anche la ritualistica mediante l’offerta agli adepti di sostanze psichedeliche per accedere al regno di Dio. Sostanze preparate esclusivamente dalle donne.
Forse non era lontano dalla verità il conoscente del mio amico runner il quale inconsapevolmente, scherzando, suppose che prima di scrivere la Divina Commedia “chissà Dante cosa si era fumato.”