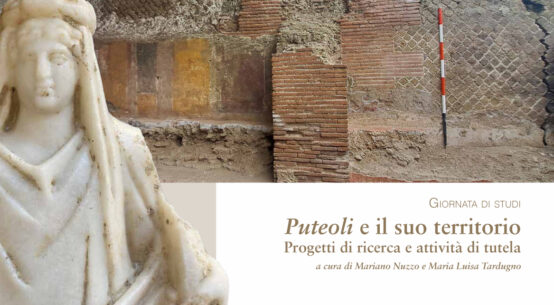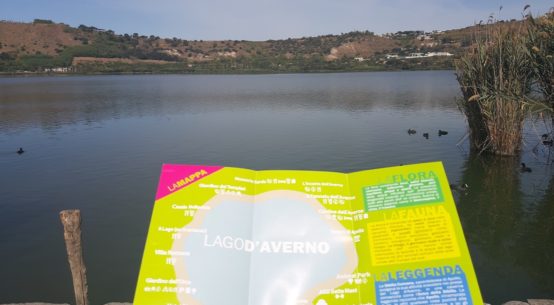Negli ultimi giorni è stato reso pubblico un lavoro scientifico il cui titolo in italiano è: “L’eruzione del 1538 nella caldera risorgente dei Campi Flegrei: implicazioni per futuri disordini e scenari eruttivi”. E’ reperibile online:
https://nhess.copernicus.org/articles/25/3421/2025/
Gli autori sono: prof Giuseppe Rolandi, Dott.ssa Claudia Troise, Dott. Marco Sacchi , Dott. Massimo Di Lascio , Prof. Giuseppe De Natale.
Non rappresenta una novità assoluta in quanto il Prof De Natale lo aveva presentato in pubblico già nel Dicembre scorso ed anche successivamente, quando la stesura dell’articolo scientifico era in fase di completamento e revisione.
Il lavoro, come dichiarato dagli stessi autori “si propone principalmente
- di ricostruire e interpretare gli eventi precedenti e successivi all’eruzione del 1538. Tale analisi segue tre direttrici principali:
- la ricostruzione accurata dei movimenti del suolo in quest’area fin dai primi tempi storici, avvalendosi di testimonianze e documentazione storica;
- la ricostruzione accurata dei movimenti di sollevamento evolutisi dal 1430 al 1538, accompagnati e seguiti da significativi eventi sismici; e l’analisi dei parametri stratigrafici e geofisici che, sebbene raccolti in epoca recente, forniscono elementi importanti per la ricostruzione e l’interpretazione dei fenomeni di turbolenza legati all’eruzione del 1538.
Infine, l’interpretazione degli eventi precedenti e successivi all’eruzione del 1538 viene utilizzata per fornire informazioni sui possibili scenari evolutivi dell’attuale agitazione”
Il sollevamento che precedette il fenomeno eruttivo avrebbe avuto inizio non prima del 1430 dopo una lunga subsidenza plurisecolare; la spinta verso l’alto sarebbe durata poco più di 100 anni prima dell’eruzione. Pubblicazioni precedenti erano arrivati ad altre conclusioni: il Parascandola indicava come inizio dell’”Upplift” l’ XI secolo d.C per un periodo complessivo ben superiore. Un lavoro più recente (2016) di Di Vito ed altri, reperibile online:
https://www.nature.com/articles/srep32245
indica come inizio il XIII° sec il che determina un sollevamento pre-eruttivo della durata di circa 300 anni.
Gli studi effettuati ed analizzati sia con la pubblicazione del 2016 (Di Vito ed altri che quella del 2025 (De Natale ed altri) prendono in esame elementi multidisciplinari utili per la comprensione di ciò che è effettivamente avvenuto.
Il recentissimo lavoro di De Natale ed altri, comprende una revisione dei risultati dei lavori precedenti; attraverso la disponibilità di un set di ulteriori documenti storici attendibili, con argomentazioni particolareggiate ottenendo risultati contrastanti .
(Ne consiglio una lettura attenta)
Nello studio si analizza la variazione di livello della “Via Herculea” che storicamente permetteva il collegamento tra Pozzuoli e Bacoli in un’area costiera, essa indirettamente sarebbe influenzata dalla deformazione nei pressi del futuro Montenuovo. Essa è “sprofondata nelle acque costiere prospicienti il Lago d’Averno ben prima del 1538 La sua non riemersione con l’eruzione, fa ipotizzare, secondo gli autori, un sollevamento complessivo di quell’area di non più di 5-7 metri negli ultimi anni che hanno preceduto l’eruzione,. Ciò è in disaccordo con quanto affermato nel pur recente lavoro di Di Vito ed altri del 2016 in cui si afferma che tale sollevamento avrebbe invece raggiunto circa 19 metri.
(Attualmente i resti della Via Herculea giacciono ad una profondità di circa 4.5 m)
Non è chiaro quale sia lo stato del sottosuolo flegreo. (In letteratura scientifica ci sono diverse ipotesi ricostruttive fino alla camera magmatica principale che sarebbe individuata a circa 8 Km di profondità) In alcuni lavori si ipotizza che durante la crisi dell’82-84 sia avvenuta una intrusione di magma dal basso fino a circa 3 Km di profondità e con un volume paragonabile a quanto eruttato con il Montenuovo. (Troise ed altri 2019) L’ andamento della sismicità che negli ultimi anni ha avuto un incremento sia in frequenza di terremoti che in intensità massima. E’ tale da far ipotizzare eventi anche di megnitudo 5 o poco superiori, (in accordo con altri studi) e con ipocentri confinati nei primi 3 Km di profondità, soprattutto se il sistema possa evolvere verso la temuta eruzione. La maggiore distribuzione dei terremoti più significativi è considerata importante per ipotizzare l’area in cui essa possa avvenire., in questo senso la zona di Solfatara Agnano può essere un sito probabile a causa della l’elevata frequenza dei sismi significativi.
Ciò in verità ha importanza scientifica ma non di protezione civile in quanto una evoluzione in tal senso determinerebbe la necessaria evacuazione in tutta la caldera a causa l’enorme rischio di sviluppo di flussi piroclastici i cui movimenti non sono affatto prevedibili.
“La distribuzione dei centri eruttivi rivela che, durante la prima fase post-caldera, essi erano distribuiti attorno al blocco risorgente. Nella seconda fase, tra i 13 edifici vulcanici, sette si sono verificati all’interno dell’area risorgente
Sembra probabile che la seconda fase post-caldera (5,8–3,7 ka) possa essere considerata il riferimento primario per definire possibili scenari eruttivi futuri, a seguito dell’eruzione del 1538 d.C”.
E’ importante osservare l’andamento della deformazione per apprezzare eventuali cambiamenti nella forma il che può rappresentare un elemento predittivo circa l’area di una eventuale eruzione.
Attualmente la forma della deformazione procede in maniera costante ed è centrata nell’area del Rione Terra dimostrando che la sorgente di spinta è immobile.
“La deformazione del suolo ai Campi Flegrei, prima e dopo l’eruzione del 1538, sembra essere stata concentrata in una piccola area, di pochi km di raggio, attorno a Pozzuoli, simile a quella osservata durante le turbolenze vulcaniche a partire dal 1970 (De Natale et al., 1991, 2006; Troise et al., 2019). Tale concentrazione concorda con la presenza di un blocco risorgente”.
Si fa riferimento a quanto sta avvenendo dall’inizio del sollevamento recente cui si da inizio negli anni 50. Esso è di circa 4.5 metri (fino al 2024) quindi ancora ben lontano da quanto avvenuto per il Montenuovo.
Solo negli ultimi anni prima dell’eruzione tale deformazione ha assunto forma diversa concentrandosi nell’a zona del futuro Montenuovo
Considerando una “reologia” delle rocce costanti ciò indicherebbe che siano ancora piuttosto lontane dal loro valore critico necessario per una possibile eruzione.
Non si esclude che l’eventuale futura eruzione possa aver inizio con un’attività freatica che potrebbe successivamente evolvere in freato – magmatica analogamente a quanto accaduto in passato.
Tali scenari negativi potrebbero prodursi in periodi di tempo maggiori rispetto a quanto avvenuto per il Montenuovo. (anche 250 anni considerando che l’energia complessiva del sistema risulta inferiore)
Il recente lavoro di De Natale (ed altri) valuta la possibilità di uno scenario migliore con una progressiva diminuzione dell’Unrest pluridecennale quindi senza eruzione finale.
Per quanto riguarda la bibliografia ritengo di dover far riferimento alla suddetta pubblicazione di De Natale (2025) reperibile online
https://nhess.copernicus.org/articles/25/3421/2025/
ed a quella di Di Vito ed altri (2016) anch’esso reperibile: